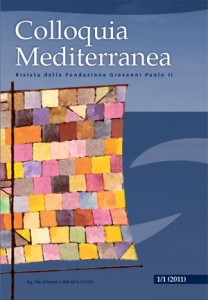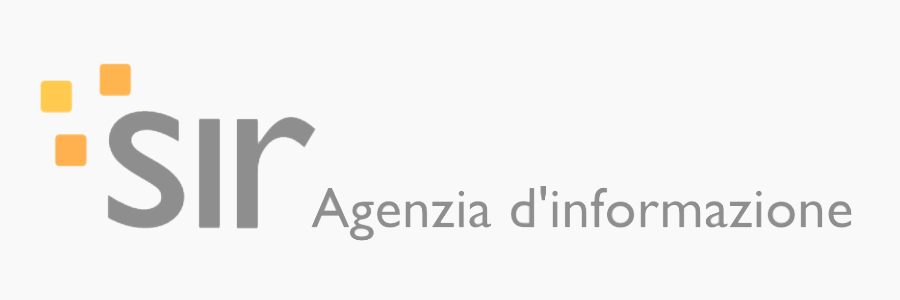Guido Bellatti Ceccoli (Strasburgo)1
- 1. Il Consiglio d’Europa e il Mediterraneo
Come premessa, data la natura di questa rivista, vorrei spiegare come il Consiglio d’Europa sia un’organizzazione internazionale a forte vocazione mediterranea, non solo sul piano giuridico, ma anche culturale e, più in generale, politico. Con sede a Strasburgo, il Consiglio è stato creato nel 1949, a seguito della seconda guerra mondiale, perché l’Europa non fosse più confrontata, in futuro, a simili catastrofi umanitarie provocate da devastanti dittature. Per questo è stato fondato su tre valori fondamentali: i diritti dell’uomo, la democrazia e lo stato di diritto. Oggi l’organizzazione conta 47 stati membri e cinque osservatori tra i quali la Santa Sede. Tra gli stati membri vanno citate le «vecchie democrazie» che si affacciano sul Mediterraneo: Francia, Grecia, Italia, Spagna e Regno Unito con Gibilterra. Ma si devono anche considerare due paesi occidentali pienamente coinvolti dalla «dimensione mediterranea», quali Malta e Monaco. Ci sono poi il Portogallo e San Marino, due stati membri del Consiglio d’Europa che non si affacciano fisicamente sul Mediterraneo ma che sono comunque profondamente legati (data la loro situazione geo-politica) alla realtà mediterranea. Abbiamo poi gli stati dell’Europa dell’Est membri del Consiglio che si possono senza dubbio definire «mediterranei» (comprendendo ovviamente quelli che si affacciano sul Mar Nero), soprattutto data la loro posizione geografica: si pensi all’Albania, alla Bosnia – Erzegovina, alla Bulgaria, a Cipro, alla Croazia, alla Georgia, al Montenegro, alla Russia, alla Slovenia, alla Turchia e all’Ucraina. Senza contare gli altri stati che pur non avendo accesso al mare sono comunque coinvolti dalle politiche mediterranee.
Dalla fine degli anni `80, oltre ad operare un allargamento verso l’Est europeo (il primo paese dell’Est a entrare nel Consiglio d’Europa è stata l’Ungheria, nel 1990, seguito poi da tutti gli altri tranne il Belarus), l’organizzazione ha anche affermato la sua politica mediterranea, e più in generale «mondialista», attraverso la creazione (nel 1989), nel suo seno, del Centro per l’interdipendenza e la solidarietà mondiale, detto Centro Nord-Sud con sede a Lisbona, aperto anche a paesi extraeuropei, che oggi conta come membro a pieno titolo il Marocco. Inoltre, sul piano delle attività giuridiche, l’organizzazione annovera da oltre un ventennio la Commissione per la democrazia attraverso il diritto, detta Commissione di Venezia, anch’essa aperta sul Mediterraneo dato che tra i suoi membri si contano (oltre a tutti i paesi membri del Consiglio d’Europa e a diversi paesi asiatici e sudamericani) l’Algeria, Israele, il Marocco, la Tunisia, e con uno «statuto speciale» l’Autorità nazionale palestinese.
Il Consiglio d’Europa, inoltre, ha rapporti di cooperazione con diversi organismi (intergovernativi o meno) molto attivi nell’area mediterranea, come l’organizzazione della Lega araba per l’educazione, la cultura e la scienza (ALECSO, con sede a Tunisi), l’Alleanza delle Civiltà (creata in seno all’ONU a New York), la fondazione Anna Lindh (Fondazione euro mediterranea per il dialogo tra culture) e la fondazione Al-Jaber.
Va poi sottolineato, riguardo alle attività legate alla libertà religiosa nel Mediterraneo, che il Consiglio d’Europa ha creato, nel 2007, gli Incontri annuali sulla dimensione religiosa del dialogo interculturale, un forum di incontro di alto livello politico che ogni anno, dal 2008, permette un dialogo aperto e diretto tra gli stati membri e osservatori, i rappresentanti delle religioni e delle altre convinzioni (atee, agnostiche, etc.), le ONG e in generale le diverse componenti sociali europee. Gli Incontri sono stati istituiti a seguito del terzo vertice dei capi di stato e di governo del Consiglio d’Europa (Varsavia, maggio 2005) nel quale è stata sottolineata l’importanza del dialogo interculturale e interreligioso. Negli Incontri si è trattato finora dell’insegnamento del «fatto religioso» (nel 2008 e nel 2009) e della relazione tra i media e le religioni (nel 2010), ed esiste la possibilità che in futuro vengano discussi altri temi legati in maniera ancora maggiore al contesto mediterraneo. In ogni caso, nelle discussioni tenute in seno agli Incontri è stato dato uno spazio rilevante al ruolo della giurisprudenza della Corte europea sulla libertà religiosa (articolo 9 CEDU), anche in relazione alla libertà di espressione (articolo 10 CEDU), per una pacifica convivenza nell’esercizio delle diverse libertà fondamentali considerate2.
I recenti eventi che hanno provocato, dalla fine del 2010, cambiamenti di enorme importanza politica nel Maghreb e più in generale nel mondo arabo, quindi nel contesto geopolitico mediterraneo (basti pensare alla svolta democratica in Tunisia e alla rivolta in atto in Libia), fanno riflettere sull’affermazione dei valori tradizionali del Consiglio d’Europa – diritti umani, democrazia e stato di diritto, da concepire come valori universali –, anche in tali realtà in piena fase di evoluzione. Non va taciuta, inoltre, l’entrata in vigore della Carta araba dei diritti dell’uomo (della Lega araba) nel 2008, che apre la via alla creazione di un sistema di protezione dei diritti umani che potrebbe in un futuro non lontano evocare il sistema creato in seno al Consiglio d’Europa. Nello stesso ordine di eventi, va menzionata l’entrata in vigore nel 1986 della Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli dell’Unione degli stati africani, ratificata da diversi paesi mediterranei (Algeria, Egitto, Libia e Tunisia), e soprattutto l’entrata in vigore, nel 2004, del suo protocollo del 1998 che istituisce una Corte africana dei diritti dell’uomo e dei popoli.
- 2. La protezione della libertà di religione al Consiglio d’Europa
Fatta questa premessa di ordine generale, vediamo quindi quale protezione è data dal Consiglio d’Europa alla libertà di religione sul piano giuridico. Dato che questa rivista non si rivolge unicamente a specialisti del diritto, ho ritenuto opportuno, per facilitare la comprensione, spiegare alcune regole e soffermarmi su alcuni concetti relativi al sistema giudiziario europeo di controllo3.
La libertà di pensiero, di coscienza e di religione è prevista dall’articolo 9 della convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)4. Una protezione particolare di tale libertà, nell’ambito del diritto all’istruzione, è data inoltre dall’articolo 2 del primo protocollo alla CEDU5. Si tratta quindi di una libertà protetta dal sistema giudiziario europeo di controllo. Organo principale di tale sistema è la Corte europea dei diritti dell’uomo (la Corte), che adotta delle decisioni (in particolare delle sentenze) obbligatorie per gli stati membri del Consiglio d’Europa. Le sentenze di merito della Corte sono adottate dalle proprie camere (istituite in seno alle sue sezioni), ma esiste la possibilità che tali sentenze vengano vagliate anche dalla grande camera della Corte, se il caso trattato solleva almeno una «grave questione» di carattere generale o relativa «all’interpretazione o all’applicazione» della CEDU (articolo 43 CEDU). L’esistenza di tali condizioni è valutata da un comitato formato da cinque giudici della Corte.
In caso di riconosciuta violazione della CEDU le sentenze della Corte producono i loro effetti giuridici sul piano delle “misure generali” (ossia riguardo alla necessità di adottare leggi o altre normative o prassi a carattere generale, per evitare che simili violazioni si producano in seguito) e delle misure individuali (nei confronti della situazione particolare del ricorrente) dal momento in cui sono passate in giudicato, ossia sono definitive.
La sorveglianza dell’esecuzione delle sentenze della Corte è affidata al comitato dei ministri, che chiude definitivamente i casi quando constata – con l’assistenza del «servizio dell’esecuzione delle sentenze della Corte», che fa capo alla «direzione generale per i diritti dell’uomo e le questioni giuridiche» – che il governo responsabile della violazione ha dato piena esecuzione alla sentenza, adottando le misure generali e individuali richieste.
L’articolo 9 CEDU ha una giurisprudenza notevole, formatasi in particolare a partire dall’inizio degli anni ’90, dato che negli ultimi anni le libertà da esso protette hanno assunto un grande rilievo nella realtà dei paesi europei. L’articolo 9 non va tuttavia visto solo come uno strumento destinato a regolare situazioni esogene, ossia problemi legati all’immigrazione e alle sue conseguenze, e non va visto solo nell’ottica del ruolo dell’islam nelle società europee. In effetti, in molti casi l’oggetto del contendere è stata la neutralità religiosa dello stato, ossia la richiesta di laicità nei confronti di stati considerati dai ricorrenti ancora troppo influenzati dalla loro tradizione religiosa.
La Corte è chiamata in ogni caso a esercitare un compito complesso, dato che non deve tener conto soltanto del disposto dell’articolo 9, dell’articolo 2 del primo protocollo e della propria giurisprudenza in materia, ma anche delle circostanze del singolo caso (che possono dar luogo a decisioni ben diverse in casi apparentemente analoghi) e della normativa pertinente in vigore nel paese considerato. La Corte, inoltre, deve tener conto della realtà del momento, senza tuttavia eccedere in tal senso, perché in tal caso rischierebbe di produrre decisioni di natura più politica che giuridica, indebolendo l’efficacia (oltre che il prestigio) del sistema di controllo della CEDU di cui è l’elemento centrale.
La Corte è entrata in funzione nel 1959 per esaminare i ricorsi in cui si lamentavano violazioni della CEDU, aperta alla firma nove anni prima. Per un lungo periodo, l’articolo 9 ha avuto un’applicazione assai limitata, fino alla sentenza sul caso Kokkinakis del 1993 (v. oltre) con la quale per la prima volta la Corte ha riconosciuto alla libertà prevista dall’articolo 9 il carattere di fondamento di una società democratica (assise d’une société démocratique), definendone poi, secondo tale prisma, i contorni. Dato che la democrazia, assieme ai diritti umani e allo stato di diritto, è uno dei valori fondamentali del Consiglio d’Europa, può sembrare logico rinviare a tale concetto, presente inoltre nel secondo comma dell’articolo 9. Tuttavia, il riferimento in questione ha una portata più ampia, e assurge a una sorta di criterio interpretativo superiore. In altri termini, il rispetto della libertà individuale da parte dello stato deve in primis conformarsi ai principi dello stato democratico.
Vediamo quindi cosa prevede esattamente l’articolo 9 della CEDU, e quali sono state alcune delle sue applicazioni giurisprudenziali maggiormente rilevanti.
Articolo 9. Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
- 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.
- 2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.
Vedremo poi che risulta di grande rilievo, in certi casi, anche l’articolo 2 del primo protocollo alla CEDU, che cita:
Articolo 2. Diritto all’istruzione
Il diritto all’istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo stato, nell’esercizio delle proprie funzioni in materia di istruzione e insegnamento, rispetterà il diritto dei genitori di garantire tale educazione e tale insegnamento in conformità con le loro convinzioni religiose o filosofiche.
L’articolo appena citato, anche se ha un’esistenza propria, è stato talvolta considerato come una specificazione dell’articolo 9 (v. oltre, sentenza di grande camera sul caso Lautsi). In altre parole, l’articolo 2 del primo protocollo viene considerato in determinati casi come lex specialis che assorbe il campo di applicazione dell’articolo 9.
- 3. La giurisprudenza europea sulla libertà di religione
Sarebbe troppo lungo esaminare tutte le sentenze della Corte sull’articolo 9 e sull’articolo 2 del primo protocollo, quindi mi concentrerò su alcune sentenze di rilievo (spesso di grande camera), concernenti in particolare la libertà di religione, non procedendo a un esame delle sentenze relative alla libertà di pensiero e di coscienza.
Caso Kokkinakis contro la Grecia (sentenza del 25 maggio 1993 – violazione dell’articolo 9 CEDU): ho già avuto modo di spiegare dianzi che tale sentenza ha segnato una svolta nella giurisprudenza della Corte per aver dichiarato che le libertà di cui all’articolo 9 sono un fondamento della democrazia. Inoltre, la Corte ha precisato meglio i contorni del diritto a tali libertà, iniziando a colmare dei vuoti in un settore fino ad allora quasi scevro di giurisdizione. Basta sfogliare i manuali di dottrina giuridica pubblicati prima di tale sentenza per constatare che la giurisprudenza della Corte sull’articolo 9 era scarsissima.
I fatti di causa riguardano un testimone di Geova che si è lamentato di essere stato condannato per proselitismo dai tribunali del suo paese nel 1988. Il signor Kokkinakis aveva in effetti discusso di religione con una sua vicina, moglie di una personalità della chiesa ortodossa locale. Si è trattato quindi di una violazione dell’articolo 9 perché secondo la Corte il proselitismo, in sé, non è contrario alla CEDU. Anzi, è un diritto tutelato dallo stesso articolo 9. Quel che è vietato è il proselitismo abusivo. Non vi era quindi quel «bisogno sociale imperioso» invocato dal governo greco a giustificazione della sanzione penale.
Sempre in materia di proselitismo, è stata adottata anche la sentenza Larissis e altri contro la Grecia del 24 febbraio 1998. Nella fattispecie, tre ufficiali dell’aviazione militare, pentecostali, erano stati condannati penalmente per proselitismo nei confronti di loro sottoposti e di civili (sentenze penali nazionali definitive nel 1992). La Corte ha pronunciato la non violazione dell’articolo 9 riguardo ai subordinati (dei giovani militari), dato che tentare di convertirli alla propria religione significava abusare della propria posizione di superiorità. Quindi la Grecia aveva il diritto di perseguire penalmente gli ufficiali. Diversa è stata invece la posizione della Corte riguardo al proselitismo nei confronti di persone non inquadrate nei ranghi militari (civili), quindi non sottoposte a pressioni gerarchiche: in tal caso la Grecia ha violato l’articolo 9, dato che in tal caso il proselitismo era esercitato nei limiti della libertà definita dalla CEDU e dalla sentenza Kokkinakis.
In materia di obiezione di coscienza, invece, va tenuto conto delle sentenze Thlimmenos del 6 aprile 2000 (grande camera) e Bayatyan contro l’Armenia del 27 ottobre 2009 (caso rinviato alla grande camera il 10 maggio 2010). Nel caso Thlimmenos un cittadino greco, dopo esser stato condannato penalmente per obiezione di coscienza (quando non esisteva ancora un servizio civile alternativo al servizio militare obbligatorio), qualche anno più tardi non ha potuto acquisire la qualifica professionale di commercialista, nonostante l’eccellente risultato del concorso pubblico, proprio perché aveva subìto una condanna penale per obiezione di coscienza. La Corte, in questo caso, ha concluso per la violazione dell’articolo 14 CEDU, che vieta la discriminazione, combinata con la violazione dell’articolo 9 CEDU, dato che impedire l’accesso alla professione di commercialista era una sanzione sproporzionata al fine legittimo perseguito dalle autorità greche, ossia punire le persone che hanno rifiutato di servire il loro paese, dato che la persona in questione aveva scontato una pena detentiva per tale infrazione penale. Nel caso Bayatyan, invece, il ricorrente è un testimone di Geova chiamato a svolgere il servizio militare obbligatorio nel 2001, che pur essendo pronto a effettuare un servizio civile alternativo è stato condannato a una pena detentiva, dato che la legislazione armena non prevede la possibilità di tale servizio civile.
Caso Buscarini e altri contro San Marino (sentenza di grande camera del 18 febbraio 1999 – violazione dell’articolo 9): in questo ricorso tre cittadini sanmarinesi, Cristoforo Buscarini, Emilio della Balda e Dario Manzaroli, eletti membri del parlamento nelle elezioni del 30 maggio 1993 come candidati dello stesso partito politico (il «movimento democratico»), si sono lamentati dell’obbligo loro imposto di giurare sui vangeli per accedere all’incarico parlamentare (secondo la formula prevista dal decreto del 27 giugno 1909, al quale rinviava la legge elettorale n° 36 del 1958 allora in vigore). A nulla sono valse le obiezioni del governo, che ha cercato di far valere il valore tradizionale e non cultuale del giuramento, da considerare come un impegno di fedeltà alla repubblica (e non alla religione cattolica), anche perché lo stato di San Marino, come indica il suo nome, è stato fondato da un uomo di religione, e il riferimento ai vangeli è quindi un retaggio storico legato all’identità stessa del paese. Un aspetto rilevante, nella valutazione della commissione europea dei diritti dell’uomo (ancora esistente all’epoca) e poi della Corte, è stata la percezione personale dei tre ricorrenti, che hanno considerato l’obbligo del giuramento «religioso» come una violazione di un loro diritto individuale (protetto dall’articolo 9 CEDU). Una percezione personale che non è stata considerata capace di provocare, in sé, una sentenza di violazione della CEDU in un altro caso recente (v. oltre, sentenza di grande camera sul caso Lautsi).
In materia di giuramento si segnala anche la sentenza del 21 febbraio 2008 sul caso Alexandridis contro la Grecia. Si tratta del caso di un avvocato greco che ha dovuto giurare per poter esercitare la sue funzioni forensi davanti al tribunale di primo grado di Atene, nel settembre 2005. Dato che l’unica formula di giuramento prevista era relativa ai cristiani ortodossi, l’avvocato greco è stato obbligato a dichiarare che non era un cristiano ortodosso per poter pronunciare una dichiarazione solenne sostitutiva. Secondo la Corte, il solo fatto di essere obbligato a manifestare le proprie convinzioni riguardo alla religione ha leso la libertà dell’avvocato e ha quindi costituito violazione dell’articolo 9 CEDU.
Caso Lautsi e altri contro l’Italia (sentenza di grande camera del 18 marzo 2011): data la sua importanza da un punto di vista giuridico, mi soffermerò a lungo su questo caso, detto «del crocifisso», che ha provocato anche un notevole dibattito pubblico. In questo caso, la grande camera ha concluso a maggioranza (quindici voti contro due) per la non violazione, da parte della repubblica italiana, dell’articolo 2 del protocollo n° 1 alla CEDU. Considerando questa norma come lex specialis rispetto all’articolo 9, la Corte ha deciso che, constatata la non violazione dell’articolo 2 del primo protocollo, «non si è posta nessuna questione distinta relativamente all’articolo 9».
La grande camera si è riunita due volte per deliberare, il 30 giugno 2010 (a seguito dell’udienza pubblica di cui tratterò oltre) e il 16 febbraio 2011. Nella sentenza la grande camera illustra innanzi tutto la procedura. Alla base della decisione vi è il ricorso alla Corte formulato contro l’Italia il 27 luglio 2006 da una cittadina italiana, Soile Lautsi, che ha agito anche a nome dei due figli allora minori, Dataico e Sami Albertin, che in seguito, divenuti maggiorenni, hanno confermato la loro volontà di restare in giudizio, assumendo il titolo di «secondo e terzo ricorrente»6.
Il ricorso è stato affidato alla seconda sezione della Corte, e il 1° luglio 2008 una camera di tale sezione, composta da sette giudici7, ha deciso di comunicare il ricorso al governo italiano, perché fossero esaminati al tempo stesso la ricevibilità e il merito del caso.
Il 3 novembre 2009 una camera della stessa sezione, sempre composta da sette giudici8, ha dichiarato il ricorso ricevibile e ha deciso nel merito, all’unanimità, la violazione da parte dell’Italia dell’articolo 2 del primo protocollo CEDU esaminato congiuntamente all’articolo 9 CEDU, decidendo inoltre di non pronunciarsi sulla lamentata violazione dell’articolo 14 CEDU (non discriminazione).
Il governo italiano, il 28 gennaio 2010, ha poi richiesto il rinvio del caso in grande camera, e il 1° marzo seguente un collegio di cinque giudici di grande camera ha accettato tale richiesta. La grande camera chiamata a decidere sul ricorso era composta da diciassette giudici9. Sia i ricorrenti che il governo italiano hanno presentato memorie complementari a sostegno delle loro posizioni.
Sono stati autorizzati a intervenire nella procedura scritta di grande camera trentatre membri del Parlamento europeo (congiuntamente), l’ONG Greek Helsinki Monitor (già intervenuta nella procedura innanzi alla camera), e le ONG seguenti: Associazione nazionale del libero pensiero, European Centre for Law and Justice, Eurojuris, Commission internazionale de juristes, Interights, Human Rights Watch (queste ultime tre agendo congiuntamente), Zentralkomitee der deutschen Katholiken, Semaines sociales de France, Associazioni cristiane lavoratori italiani (queste ultime tre congiuntamente).
Sono stati autorizzati a intervenire nella stessa procedura, inoltre, dieci governi (di stati membri del Consiglio d’Europa): Armenia, Bulgaria, Cipro, Russia, Grecia, Lituania, Malta, Monaco, Romania, San Marino. Due di loro (Monaco e Romania) hanno presentato memorie scritte separate. Gli altri otto governi hanno affidato di comune accordo la loro difesa a un giurista statunitense, Joseph Weiler, professore all’università di New York. Il professor Weiler quindi, a nome di quei governi, ha presentato una memoria scritta e si è espresso in udienza il 30 giugno 2010, in qualità di conseil. In tale udienza è stato affiancato dai rappresentanti degli otto governi citati, presenti in qualità di conseillers10.
La sentenza di grande camera si sofferma in primis sulle circostanze della fattispecie, illustrando le varie iniziative intraprese dalla ricorrente e le relative decisioni amministrative e giudiziarie. I suoi due figli, negli anni 2001 e 2002, hanno frequentato l’Istituto comprensivo statale Vittorino da Feltre di Abano Terme. Nelle aule dell’istituto essendo esposti dei crocifissi, il padre dei due allievi solleva la questione della loro rimozione, il 22 aprile 2002, nel consiglio di classe che il 27 maggio seguente decide di non rimuoverli (con dieci voti contro due e un’astensione).
La madre, il 23 luglio dello stesso anno, impugna tale decisione davanti al tribunale amministrativo regionale (TAR) del Veneto, per violazione del principio di laicità dello stato, basandosi su due norme costituzionali11 (l’articolo 3, principio d’uguaglianza, e l’articolo 19, libertà religiosa) e sull’articolo 9 CEDU.
Il 3 ottobre seguente il ministro della pubblica istruzione emette una circolare (n° 2666) che impone ai responsabili delle scuole italiane, tra l’altro, di garantire la presenza del crocifisso nelle aule. E circa un anno dopo, il 30 ottobre 2003, lo stesso ministro si costituisce parte nel procedimento davanti al TAR per contestare le ragioni della ricorrente, invocando due regi decreti: il n° 965 del 30 aprile 1924 (ordinamento interno delle giunte e dei regi istituti di istruzione media) e il n° 1297 del 26 aprile 1928 (regolamento generale sui servizi dell’istruzione elementare).
Il 14 gennaio 2004 il TAR solleva la questione di costituzionalità davanti alla corte costituzionale, alla luce del principio di laicità dello stato e degli articoli 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della costituzione, degli articoli 159 e 190 del decreto legge n° 297 del 16 aprile 1994 (di approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in vigore in materia d’istruzione e relative alle scuole) per quanto riguarda gli aspetti collegati agli articoli 118 e 119 dei regi decreti citati e in riferimento all’articolo 676 dello stesso decreto legge. Il decreto legge citato prevede che i comuni forniscano il mobilio delle scuole elementari e medie (articoli 159 e 160), e l’articolo 119 del decreto reale del 1928 include il crocifisso tra i beni mobili destinati alle aule, mentre l’articolo 118 del regio decreto del 1924 prevede che ogni aula deve essere provvista di un ritratto del re e di un crocifisso. L’articolo 676 del decreto, poi, dispone che le disposizioni non comprese nel testo unico restino in vigore (salve le norme con esso incompatibili).
La corte costituzionale, il 15 dicembre 2004, dichiara la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, dato che la controversia si riferisce a norme (gli articoli 118 e 119 di cui sopra) che non hanno rango legislativo, ma solo regolamentare12.
Tre mesi dopo, il 17 marzo 2005, il TAR rigetta il ricorso, statuendo che i regi decreti citati erano ancora in vigore e sottolineando che la presenza del crocifisso nelle aule non contrastava con il principio di laicità dello stato, considerato come parte integrante del patrimonio giuridico europeo delle democrazie occidentali. In effetti, secondo il TAR, il crocifisso è un simbolo storico-culturale, portatore in quanto tale di un valore identitario per il popolo italiano, e simbolizza il percorso storico e culturale italiano e più in generale europeo. Inoltre, il crocifisso incarna un sistema di valori che innervano la costituzione italiana. Nella sua motivazione, più precisamente, il TAR fa riferimento alla tradizione giudeo-cristiana, nella quale i valori di tolleranza e di rispetto della dignità umana sono posti al centro della fede religiosa. Tolleranza, uguaglianza e libertà, idee su cui si fonda lo stato laico moderno, sono proprie al cristianesimo, nel quale l’amore per il prossimo è basato sul concetto di “carità”, che prevale sulla stessa fede. Il TAR trova anche un legame tra cristianesimo e illuminismo, essendo entrambi fondati sul rispetto della dignità umana, nel percorso che ha portato alla dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino e alla conseguente affermazione dello stato laico contemporaneo. I valori cristiani sono quindi fondatori dello stato laico (malgrado l’inquisizione, l’antisemitismo e le crociate), e innervano la costituzione repubblicana, fondata anch’essa sulla libertà individuale e sul rispetto del prossimo. Il crocifisso simboleggia dunque valori chiave della costituzione: libertà, uguaglianza, dignità umana e tolleranza religiosa, quindi laicità dello stato. Sarebbe quindi paradossale, afferma il tribunale, togliere i crocifissi della aule in nome della laicità dello stato, dato che una delle fonti di tale laicità è proprio la religione cristiana. Secondo il TAR, l’esposizione del crocifisso in classe è anche un modo di insegnare ai numerosi studenti extracomunitari presenti nelle scuole italiane il rispetto della diversità e il rifiuto dell’integralismo, dato che l’incontro tra diverse culture, perché non diventi scontro, si deve basare sull’affermazione – anche «simbolica» – dell’identità cristiana, che si fonda sul rispetto delle differenze.
Certo, spiega il TAR, in generale i simboli religiosi, per le diverse religioni, implicano una logica di esclusione (dalla società e nelle relazioni interpersonali), perché chi crede in una religione particolare pensa necessariamente che sia l’unica Verità e che chi non crede in essa sia nel torto, quindi vada escluso. Un’esclusione che secondo il TAR sarebbe un precetto obbligatorio per tutte le religioni, con una sola eccezione: la religione cristiana. Perché se un cristiano rifiuta e esclude un ateo (o chi professa una diversa religione) si rende reo di un’abiura della propria religione, dato che con tale rifiuto nega radicalmente lo stesso cristianesimo, per il quale la carità, ossia il rispetto del prossimo, deve prevalere sulla fede religiosa. Vedere nell’esposizione del crocifisso l’esclusione o il rifiuto sarebbe come negare il suo valore di accettazione e rispetto di ogni essere umano. Il crocifisso in classe, quindi, non esclude nessuno e non impone né vieta niente a nessuno, ma implica semplicemente una riflessione – necessariamente condotta dagli insegnanti – centrale per le finalità perseguite dall’educazione e dall’insegnamento dispensato nella scuola pubblica, sulla storia italiana e sui valori comuni della nostra società, giuridicamente percepiti dalla costituzione, tra i quali, in primo luogo, la laicità dello stato.
Il 13 aprile 2006 il consiglio di stato, presso il quale la ricorrente aveva impugnato la sentenza del TAR del Veneto, con la sua sentenza n° 556 conferma la compatibilità del crocifisso con il principio di laicità, perché la sua presenza nelle aule, fondata giuridicamente sui regi decreti del 1924 e del 1928, simbolizza l’origine religiosa di valori fondamentali per la civiltà italiana: la tolleranza, il mutuo rispetto, la valorizzazione della persona, l’affermazione dei suoi diritti, la considerazione della sua libertà, l’autonomia della coscienza morale rispetto all’autorità, la solidarietà umana, il rifiuto di ogni forma di discriminazione. Valori che definiscono la laicità nell’attuale ordine legislativo statale. L’esposizione del crocifisso in classe, anche in una prospettiva laica distinta da quella religiosa che gli è propria, può avere una funzione simbolica altamente educativa, a prescindere dalla religione professata dagli allievi.
Il consiglio di stato, oltre a far proprie le motivazioni del TAR, fa riferimento alla giurisprudenza della corte costituzionale, che ha definito giuridicamente la laicità (non prevista espressamente nella costituzione), riferendosi agli articoli 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della costituzione, stabilendo le sue necessarie condizioni d’uso (necessarie perché senza di esse la laicità resterebbe un principio non giuridico, quindi confinato a dispute ideologiche) in riferimento alle tradizioni culturali e agli usi e costumi nazionali. Elementi che possono differire da una nazione a un’altra.
Sempre secondo il consiglio di stato, il crocifisso può avere diversi significati e finalità, prima di tutto a seconda del luogo in cui si trova. In un luogo di culto è un simbolo religioso. In una scuola, anche se può valere come simbolo religioso per i fedeli cristiani, ha per tutti (credenti o meno) un valore di non discriminazione religiosa, evocando valori di civiltà che sottendono e ispirano l’ordine costituzionale italiano. Un simbolo «laico», dunque, con potenzialità altamente educative per tutti.
La sentenza della grande camera della Corte europea, dopo aver illustrato tali circostanze, spiega quale sia stata l’evoluzione del diritto e della prassi italiana in materia (dal paragrafo 17 al paragrafo 25). Dopo un excursus storico-giuridico che copre il periodo dal 1859 al 1871 sulle norme relative al crocifisso e alla religione di stato, la sentenza tratta della circolare n° 68 del 22 novembre 1922 del ministro della pubblica istruzione, nella quale si lamenta il fatto che in molte scuole elementari italiane il ritratto del re e il crocifisso fossero stati illegalmente tolti e si ordina quindi di ripristinarne l’affissione. La Corte poi ricorda l’obbligo del crocifisso nelle aule previsto dal regio decreto del 1924 e la norma del regio decreto del 1928 nel quale il crocifisso figura tra le forniture necessarie alle aule delle scuole pubbliche. Siamo alla vigilia della firma dei patti lateranensi (11 febbraio 1929) con i quali è stata risolta la «questione romana» e il cattolicesimo è stato confermato come religione ufficiale dello stato (con rinvio all’articolo 1 dello statuto albertino del 1848 nel quale la «religione cattolica, apostolica e romana» è dichiarata sola religione di stato). Riguardo alla costituzione repubblicana del 1948, poi, la Corte richiama gli articoli 7 e 8: il primo rinvia ai patti lateranensi prevedendone la possibile modifica senza applicare la normale procedura di revisione costituzionale; il secondo sancisce l’uguaglianza della libertà delle religioni davanti alla legge, con riferimento particolare alle religioni diverse dalla cattolica.
Viene menzionato inoltre il nuovo concordato tra stato e chiesa cattolica del 18 febbraio 1984, con il quale è stato stabilito che il principio dei patti lateranensi secondo il quale la religione cattolica è la sola religione di stato non è più in vigore. Da allora, in altri termini, la religione cattolica non è più religione ufficiale dello stato italiano.
La corte costituzionale il 12 aprile 1989 ha emesso una sentenza (n° 203) nella quale, pronunciandosi sul carattere non obbligatorio dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, ha affermato il valore costituzionale del principio di laicità, stabilendo che tale principio implica la garanzia della protezione della libertà religiosa nell’ambito del pluralismo confessionale e culturale (e non l’indifferenza dello stato nei confronti delle religioni).
Abbiamo visto che in seguito, riguardo al caso di specie, la corte costituzionale si è dichiarata incompetente (decisione del 15 dicembre 2004), e che nel febbraio 2006 il consiglio di stato ha dichiarato tale presenza compatibile con il principio di laicità dello stato.
Va tuttavia segnalato che nel 2000 la corte di cassazione italiana (quarta sezione penale) ha preso una decisione che contrasta fortemente con la sentenza del consiglio di stato sopra menzionata. Un cittadino selezionato per svolgere le funzioni di scrutatore nelle elezioni del 1994, a Cuneo, si è rifiutato di assolvere tale compito perché nei seggi elettorali, allestiti in scuole e altri edifici pubblici, erano presenti dei crocifissi. La presenza di tale simbolo religioso avrebbe quindi leso i suoi diritti costituzionali, ed in particolare la sua libertà di coscienza. Questo cittadino è stato quindi perseguito penalmente e condannato a pagare un’ammenda. La corte di cassazione, in data 1° marzo 2000, gli ha dato ragione e ha annullato la sentenza di condanna penale, considerando che la presenza del crocifisso nei seggi elettorali lede i principi di laicità e di imparzialità dello stato, nonché il principio di libertà di coscienza di coloro che non si riconoscono in tale simbolo13. Per giungere a tale conclusione la corte di cassazione si è riferita anche alla sentenza della corte costituzionale n° 203 del 1989, che afferma il principio di laicità dello stato in senso positivo (vedi sopra), e anche a una successiva sentenza (n° 334 dell’8 ottobre 1996) nella quale la corte costituzionale dichiara il «supremo principio costituzionale di laicità o non confessionalità dello stato» a salvaguardia della libertà di religione «in regime di pluralismo confessionale e culturale». In somma, la corte di cassazione, su tali basi, rigetta chiaramente l’idea che l’esposizione del crocifisso sia giustificata in quanto simbolo di un’intera civiltà e di una coscienza etica comune, ossia nega che il crocifisso incarni un valore universale, indipendente da una religione specifica. Questa decisione è in aperto contrasto anche con il parere del consiglio di stato del 27 aprile 1988 (n° 63), nel quale sono espressi i concetti appena citati a favore dell’esposizione del crocifisso. Sulla questione esiste quindi in Italia un contrasto evidente tra la giurisprudenza del consiglio di stato e quella della corte di cassazione.
Allargando la sua analisi alla situazione europea, la Corte ha esaminato, nel quadro della sua valutazione del caso, anche come viene regolata la questione della presenza di simboli religiosi nelle scuole pubbliche negli altri 46 stati membri del Consiglio d’Europa? Si tratta di una questione di fondamentale importanza per la Corte (v. paragrafi 26-28 della sentenza di grande camera), perché l’esistenza o meno di un consensus europeo in materia è stata tenuta in considerazione per decidere sull’esistenza della violazione della CEDU.
La presenza di simboli religiosi nelle scuole pubbliche è vietata espressamente in tre paesi: la Francia (esclusi però la regione Alsazia e il dipartimento loreno della Mosella14), la Georgia e l’ex repubblica jugoslava di Macedonia. Tale presenza è prevista espressamente, oltre che in Italia, solo in Austria, in alcuni Länder tedeschi, in qualche cantone svizzero e in Polonia. Tuttavia, in Polonia la corte costituzionale, con decisione del 20 aprile 1993, ha statuito che l’esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche, pur essendo compatibile con la libertà di religione e con il principio di separazione tra stato e chiesa, non deve essere considerata un obbligo15.
In sei paesi, poi, il crocifisso è esposto nelle aule benché non esista una disposizione specifica in tal senso. Si tratta di Spagna, Grecia, Irlanda, Malta, San Marino e Romania. In Romania la corte suprema, con una sentenza dell’11 giugno 2008, ha annullato una decisione del consiglio nazionale per la lotta alla discriminazione del 21 novembre 2006 che raccomandava al ministero dell’educazione di regolamentare la materia e in particolare di esporre dei simboli religiosi soltanto durante i corsi di religione o nelle aule destinate all’insegnamento religioso. La corte suprema rumena ha concluso quindi che la decisione di esporre dei simboli religiosi nelle classi appartiene alla comunità scolastica, composta dagli insegnanti, dagli allievi e dai loro genitori. Questa posizione spiega perché la Romania, nella procedura di grande camera, abbia presentato una memoria scritta nella quale ha ribadito la posizione assunta dalla sua corte suprema.
Anche in Spagna la questione ha sollevato delle controversie: il tribunale superiore di giustizia di Castilla-Léon il 14 dicembre 2009 ha deciso che i simboli religiosi devono essere tolti dagli edifici scolastici su domanda espressa dei genitori, anche qualora si tratti dei genitori di un solo allievo16.
Va poi notato che in Germania la questione è stata trattata dalla corte costituzionale federale, che il 16 maggio 1995 ha deciso che un’ordinanza bavarese che imponeva il crocifisso nelle aule era contraria al principio di neutralità dello stato, quindi era difficilmente compatibile con la libertà di religione degli allievi che non si riconoscevano nella religione cattolica. In seguito, il parlamento bavarese ha adottato una nuova ordinanza con la quale ha riconosciuto ai genitori la possibilità di contestare la presenza del crocifisso e di cercare di raggiungere un compromesso o di trovare una soluzione ad personam.
In Svizzera il tribunale federale il 26 settembre 1990 ha considerato un’ordinanza comunale, con la quale si prevedeva la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole elementari, incompatibile con il principio di neutralità confessionale dello stato sancito dalla costituzione federale, pur non considerando illegale la presenza del crocifisso in altri locali scolastici.
In conclusione, nella stragrande maggioranza dei paesi membri del Consiglio d’Europa la questione della presenza di simboli religiosi nelle scuole pubbliche non è regolata da specifiche disposizioni legislative o di altra natura. Le decisioni giudiziarie adottate in merito in alcuni stati, inoltre, dimostrano come la questione sia ancora oggetto di dibattito.
Sul piano del diritto stabilito dalla CEDU, la Corte si è occupata in primo luogo della pretesa violazione dell’articolo 2 del protocollo n° 1 e dell’articolo 9. La sentenza di camera del 3 novembre 2009, completamente ribaltata dalla grande camera, aveva deciso all’unanimità per la violazione, dato l’obbligo degli stati di astenersi dall’imporre, direttamente o indirettamente, un credo religioso o non religioso in luoghi dipendenti dallo stato nei quali le persone coinvolte sono in situazioni di particolare vulnerabilità, sottolineando come la scuola sia un ambito estremamente sensibile in tal senso. Il crocifisso, inoltre, è soprattutto un simbolo religioso, quindi imporne la presenza in classe, in una scuola pubblica, significa ledere le idee laiche della ricorrente e perturbare emotivamente quegli allievi che, come i suoi due figli, sono di fede non cristiana o non hanno nessuna fede religiosa. Si tratta in sostanza di un «diritto negativo», ossia di una libertà di religione che esige dallo stato l’assenza di qualunque simbolo religioso o ateo. Soprattutto quando tale simbolo è imposto a persone che non possono evitarlo. Lo stato, nell’educazione pubblica, sempre secondo la camera della Corte, è tenuto a osservare dunque una «neutralità confessionale» particolare, dato che l’istruzione va garantita a tutti senza distinzioni basate sull’appartenenza religiosa, favorendo la maturazione del pensiero critico degli allievi. La Corte non vede poi come imporre il crocifisso, ineluttabilmente associato alla religione maggioritaria nel paese, possa favorire il pluralismo educativo essenziale all’esistenza di una vera «società democratica» ai sensi della CEDU. Esporre obbligatoriamente il crocifisso nelle aule della scuola pubblica lede quindi il diritto dei genitori di educare i loro figli secondo le loro convinzioni e viola il diritto degli studenti di credere o di non credere. Lo stato, nell’esercizio di una funzione pubblica particolarmente sensibile (la pubblica istruzione), non rispetta in tal modo la necessaria neutralità, quindi viola la CEDU.
La Corte, in tale sentenza, cita a sostegno delle sue tesi, inter alia, la sentenza Buscarini contro San Marino (v. sopra), dato che anche in tal caso era stata pronunciata (in grande camera17), una violazione della libertà religiosa e di coscienza (articolo 9). Benché si trattasse di una fattispecie ben diversa (un obbligo «positivo» imposto ai ricorrenti, e al di fuori dall’ambito scolastico), la questione centrale pertinente è il margine di discrezionalità riconosciuto allo stato nel rispetto della libertà in questione. In altre parole, fino a che punto le tradizioni culturali, storiche e religiose di uno stato gli permettono di adottare certe decisioni, come quelle di esporre simboli religiosi, richiedere un giuramento sui vangeli, etc.? Non è un caso se la sentenza Buscarini viene citata, riguardo alla sentenza di grande camera sul caso Lautsi, anche nel parere dissidente del giudice Malinverni (Svizzera), al quale si è associato il giudice Kalaydjieva (Bulgaria), nella quale si sottolinea il valore indubbiamente religioso del crocifisso, quindi la fondatezza della sentenza di violazione adottata dalla camera: «A mio parere, la presenza del crocifisso nelle aule va ben aldilà dell’uso dei simboli in un contesto storico specifico. La Corte ha del resto già statuito che il carattere tradizionale di un testo utilizzato da alcuni parlamentari per giurare non privava tale testo della sua natura religiosa»18. E rinvia quindi, in nota, alla sentenza Buscarini.
Vediamo adesso, in sintesi, quale posizione ha assunto il governo italiano davanti alla grande camera della Corte.
La posizione del governo italiano riguardo alla decisione della camera denuncia innanzitutto la mancanza di un esame comparato che metta in luce quanto avviene nei paesi europei in materia. Una mancanza che, come abbiamo visto, è stata colmata dalla grande camera. L’Italia ha voluto in sostanza far valere l’assenza di un approccio comune nei paesi europei dal quale dovrebbe derivare un notevole margine di apprezzamento di ogni stato nel regolare la materia. In altre parole, la corte non avrebbe dovuto condannare l’Italia nel 2009, perché lo stato ha agito nell’ambito di un suo potere discrezionale legittimo, data la mancanza di un consensus europeo favorevole al divieto del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche. Inoltre, la «neutralità confessionale» non va intesa, secondo il governo italiano, come esclusione di ogni relazione tra stato e religioni, ma deve basarsi su una visione della laicità nella quale lo stato tenga conto in maniera equa delle esigenze di chi crede e di chi non crede in una data religione. La sentenza di camera, invece, favorisce l’approccio antireligioso della ricorrente19, quindi impone allo stato un atteggiamento parziale (a favore di chi non crede, in sostanza), non neutro.
Il governo sottolinea che ognuno può interpretare diversamente un simbolo, e «la croce», oltre che come simbolo religioso, può essere visto come simbolo culturale e identitario, di democrazia e civiltà occidentale.
Il governo sottolinea poi che il crocifisso è un’immagine, ossia un «simbolo passivo», che non impone un comportamento «attivo» degli allievi (e dei loro genitori) e che non influenza il contenuto dell’insegnamento scolastico. Il crocifisso, inoltre, esprime una tradizione secolare che in Italia lega stato, popolo e cattolicesimo; quindi dando ragione ai ricorrenti la Corte avrebbe violato il diritto della collettività italiana di trasmettere la sua cultura e il diritto degli allievi italiani di poterla scoprire. Senza contare che la Corte, nella sentenza di camera (sempre secondo il governo), tenendo conto di un «rischio potenziale» di perturbamento emozionale degli allievi, avrebbe allargato discutibilmente il campo di applicazione dell’articolo 2 del protocollo n° 1 e dell’articolo 9 CEDU. La camera non avrebbe dovuto, poi, considerare negativamente il fatto che la religione cattolica è condivisa dalla grande maggioranza degli italiani, ma riconoscere e proteggere tale tradizione nazionale e il sentimento popolare dominante, lasciando allo stato il compito di valutare ed equilibrare gli interessi in gioco (sempre secondo la visione italiana del «margine di apprezzamento»). L’Italia si riferisce, per fondare tale assunto e far valere il suo approccio particolare alla laicità, anche alla giurisprudenza della Corte secondo la quale non costituisce una violazione della CEDU prevedere nei programmi di insegnamento una posizione preponderante della religione maggioritaria (senza che ciò costituisca un’influenza indebita o un tentativo di indottrinamento)20.
Secondo il governo, inoltre, l’articolo 2 del primo protocollo (seconda frase) si applica solo ai programmi scolastici, quindi la «condanna» di camera sarebbe ingiustificata, essendo motivata soltanto dal fatto che gli allievi si consideravano immersi, nel loro percorso educativo, in un ambiente scolastico segnato da una religione determinata (a causa della presenza del crocifisso). Come considerare valida tale motivazione quando, secondo la sua stessa giurisprudenza, la CEDU ammette – in generale – che ci siano «religioni di stato», o che se ne preferisca una («dominante») rispetto a un’altra, anche nel settore dell’insegnamento? Senza contare che la presenza del crocifisso in aula non avrebbe ridotto la possibilità della ricorrente di educare i suoi figli secondo le sue convinzioni filosofiche, anche considerato che l’educazione dei genitori avrebbe un’influenza maggiore di quella impartita a scuola.
Il governo, inoltre, afferma che la presenza del crocifisso aiuta a far capire meglio agli allievi la società nella quale si dovranno integrare, sviluppando il loro spirito critico riguardo alle questioni religiose, in un’atmosfera serena e senza proselitismo. Sembra di capire che tale argomento del governo si applica, in particolare, agli allievi figli di immigrati, soprattutto di religione islamica (com’è suggerito anche dal riferimento agli studenti musulmani fatto subito dopo) o comunque non cattolici. E aggiunge che l’approccio della scuola italiana alle altre religioni (minoritarie) è benevolo, permettendo di portare il velo islamico, di festeggiare (spesso) il ramadan, di organizzare l’insegnamento di altre religioni riconosciute, di permettere agli studenti ebrei di non sostenere esami il sabato, e così via.
Il governo si preoccupa inoltre dei diritti della maggioranza dei genitori, che vogliono che il crocifisso sia mantenuto nelle aule. Una posizione democraticamente espressa, nel caso di specie, dal consiglio di classe. Togliere i crocifissi sarebbe dunque l’abuso di una minoranza (abus de position minoritaire, paragrafo 40), in conflitto, inoltre, con il dovere dello stato di favorire la soddisfazione dei bisogni religiosi dei cittadini.
Vediamo ora la posizione assunta dai ricorrenti davanti alla grande camera. Secondo loro, esporre il crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche è un’ingerenza illegittima nel loro diritto alla libertà di pensiero e di coscienza, e viola il principio del pluralismo nell’educazione, dato che esprime una preferenza dello stato per una data religione in un luogo, la scuola pubblica, dove si formano le coscienze degli allievi. Lo stato viola in tal modo un altro suo obbligo, ossia quello di proteggere particolarmente i minorenni da ogni forma di indottrinamento e di propaganda. Simbolo della religione dominante, il crocifisso permea l’ambiente educativo e viola così il diritto degli allievi di ricevere un’educazione pluralista capace di sviluppare una capacità di giudizio critico. La ricorrente, essendo a favore della laicità, ritiene che sia stato violato il suo diritto a far educare i suoi figli conformemente alle sue convinzioni filosofiche.
Per i ricorrenti il crocifisso è un simbolo religioso, e non un simbolo culturale; non si tratterebbe nemmeno di un simbolo dell’identità nazionale, com’è invece la bandiera italiana, secondo la costituzione. Citando la sentenza della corte costituzionale tedesca del 16 maggio 1995, i ricorrenti affermano che dare al crocifisso un significato profano significa togliergli il suo significato originario e desacralizzarlo. Anche affermarne il carattere «passivo» non è accettabile, dato che materializza una realtà cognitiva, intuitiva ed emozionale che va aldilà di quel che è immediatamente percettibile. La presenza del crocifisso nelle aule, sempre riferendosi alla sentenza tedesca, evocherebbe chiaramente il contenuto della fede religiosa e servirebbe a propagandarla.
I ricorrenti ricordano poi la sentenza Dahlab contro la Svizzera del 15 febbraio 2001, nella quale la Corte ha sottolineato la forza particolare dei simboli religiosi in ambito scolastico (nel caso di specie si trattava del divieto del velo islamico imposto a un’insegnante).
Ogni stato democratico deve garantire libertà di coscienza, pluralismo e uguaglianza di trattamento, ed il principio fondamentale di laicità delle istituzioni implica innanzitutto la neutralità dello stato, che deve distaccarsi dalle religioni e avere un’identica attitudine riguardo a tutti i diversi orientamenti religiosi. In altre parole, la neutralità obbliga lo stato a creare uno spazio neutro nel quale tutti possano vivere le loro convinzioni. Imponendo il crocifisso lo stato italiano, sempre secondo i ricorrenti, ha fatto il contrario.
I ricorrenti distinguono anche tra ateismo di stato (che nega la libertà religiosa imponendo una visione atea) e laicità (che afferma invece la libertà religiosa e filosofica di tutti), sostenendo ovviamente l’applicazione di quest’ultima.
La questione della natura maggioritaria o minoritaria è sottolineata anch’essa dai ricorrenti, dato che ritengono che lo stato debba proteggere le minoranze da un ingiusto despotisme de la majorité, anche vietando il crocifisso nelle aule.
In conclusione, rispetto alla posizione del governo che ritiene che togliere il crocifisso lederebbe l’identità culturale nazionale, i ricorrenti credono che mantenerlo sia incompatibile con i principi fondamentali del pensiero politico occidentale e dello stato liberale, e sia in contrasto evidente con una democrazia aperta e pluralista e con il necessario rispetto delle libertà individuali consacrate dalla costituzione e dalla CEDU.
Come abbiamo visto, nella procedura di grande camera sono intervenuti anche diversi «terzi», che pur non essendo tecnicamente «parti» hanno dato un contributo notevole alla riflessione, attraverso le loro memorie scritte e nel corso dell’udienza pubblica della Corte, tenutasi il 30 giugno 2010. L’intervento di ben dieci governi fa riflettere sull’importanza del caso. Otto su dieci, tramite il loro rappresentante, hanno fatto valere una posizione comune di sostegno alle tesi italiane. In particolare, questi paesi hanno fatto valere la loro interpretazione del concetto di neutralità, che non va confuso (come avrebbe fatto la camera della Corte) con quello di laicità. In effetti, optare per lo stato laico vuol dire imporre a tutti una rigida separazione tra stato e religione senza rispettare le differenze esistenti tra i vari paesi europei, dove il crocifisso simbolizza (oltre che la religione) l’identità nazionale, che non può prescindere dalle sue radici religiose. Occorre quindi che le relazioni tra stato e religioni siano regolate a seconda dei casi, in maniera variabile a seconda della storia e delle tradizioni di ogni paese. Stabilire un divieto collettivo rispetto ai simboli religiosi equivarrebbe a imporre una regola unica, ossia la rigida separazione tra stato e chiesa. Ora, una tale soluzione «laica», di natura politica, non sarebbe neutra, ma favorirebbe la posizione laica rispetto a quella religiosa, prendendo chiaramente posizione. Questo discorso vale in particolare per l’educazione scolastica, dove togliere il crocifisso dalle aule sarebbe una precisa scelta di campo. «Un muro vuoto non è un muro neutro», come ha affermato il professor Weiler all’udienza, soprattutto quando su quel muro il crocifisso c’è sempre stato. La Corte dovrebbe intervenire quando le scelte dello stato in questo campo sono inaccettabili, quindi estreme, profilando in tal modo il rischio di una violazione della CEDU o di un suo protocollo. Un dovere statale di particolare importanza (rispettato dall’Italia), secondo tale posizione collettiva, è invece l’affermazione del pluralismo e della tolleranza nei programmi d’insegnamento.
Gli altri due governi «terzi» hanno espresso le loro posizioni per iscritto. Oltre alla memoria della Romania, che sostiene l’ampiezza del margine di apprezzamento dello stato (non essendoci un consensus europeo in materia), ribadendo la posizione espressa sulla questione della presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche dalla sua corte suprema (v. sopra), ha presentato una sua memoria il principato di Monaco. Il governo monegasco, in sintesi, sostiene la posizione italiana condividendo l’idea secondo la quale il crocifisso sarebbe un simbolo «passivo» che testimonia di un’identità nazionale radicata nella storia. Inoltre, il principio di neutralità dello stato obbliga lo stato medesimo a non esporre un simbolo religioso là dove non è mai stato esposto, mentre deve lasciarlo là dove è sempre stato presente (come nelle aule scolastiche italiane).
Per motivi di spazio, non posso soffermarmi sulle posizioni espresse dagli altri terzi intervenuti, ma rinvio alla loro lettura dato che in esse si riscontrano diverse considerazioni di notevole interesse (paragrafi 50-56 della sentenza di grande camera).
Vediamo quindi come queste posizioni siano state valutate dalla grande camera per giungere alla sua decisione di non violazione (paragrafi 57 e seguenti della sentenza).
In primo luogo, la Corte precisa che la sua valutazione riguarda soltanto la pretesa violazione da parte dell’Italia dell’articolo 2 del primo protocollo e dell’articolo 9 della CEDU nel caso di specie. In altre parole, la Corte non si occupa della presenza del crocifisso in luoghi diversi dalle aule delle scuole pubbliche italiane, né della compatibilità di tale presenza con il principio di laicità alla luce del diritto italiano. La Corte precisa inoltre che le visioni di chi si considera laico sono da considerare «convinzioni filosofiche» ai sensi dell’articolo 2 del protocollo n° 1 e dell’Articolo 9 della CEDU, e quindi meritano di essere valutate dalla Corte stessa.
Riguardo alla posizione della ricorrente, l’articolo 2 del protocollo è considerato lex specialis rispetto all’articolo 9, quindi l’esame della Corte si concentra sulla disposizione del protocollo (seconda frase), dato che una dichiarazione di non violazione di tale norma farebbe cadere (come è stato nel caso di specie) ogni considerazione riguardante la norma generale (articolo 9). L’articolo 9 resta comunque rilevante perché sancisce il fondamentale dovere dello stato «di neutralità e di imparzialità» (sentenza Folgerø contro Norvegia del 29 giugno 2007, paragrafo 84). Il dovere dello stato di garantire in maniera imparziale e neutra l’esercizio delle diverse religioni e convinzioni, religiose o meno, è stato affermato in diverse occasioni, dato che il ruolo dello stato consiste nel contribuire all’ordine pubblico, alla pace religiosa e alla tolleranza in una società democratica (v. ad es. sentenza Leyla Şahin contro Turchia del 10 novembre 2005, paragrafo 107).
Il termine «rispettare» di cui all’articolo 2 del primo protocollo crea un obbligo positivo dello stato, ma le condizioni di tale rispetto variano notevolmente da un caso all’altro, data la varietà delle realtà esistenti nei paesi membri, che beneficiano quindi di un largo margine di apprezzamento per determinare le misure da adottare al fine di assicurare tale rispetto. Questo avviene nella valutazione dello spazio da accordare alla religione nei programmi di insegnamento, di competenza degli stati, con soluzioni che possono variare notevolmente a seconda dei paesi e della situazione contingente. Anche includendo insegnamenti con determinati caratteri religiosi o filosofici.
Esiste comunque un limite che gli stati non possono superare: l’insegnamento deve essere obiettivo, critico e pluralista, permettendo lo sviluppo negli allievi di uno spirito critico, in particolare nei confronti del «fatto religioso», in un’atmosfera serena, senza proselitismo, ed evitando un indottrinamento che potrebbe contrastare con le convinzioni religiose o filosofiche dei genitori, e tutto ciò in nome del pluralismo educativo.
La Corte ritiene che la presenza del crocifisso nelle aule rientri nell’ambito applicativo dell’articolo 2 del protocollo n° 1, contrariamente alla tesi del governo italiano secondo il quale tale ambito resterebbe confinato al contenuto dei programmi scolastici. Dato che secondo la normativa italiana l’allestimento dei locali scolastici è a carico delle pubbliche autorità, si è nel campo dell’esercizio delle funzioni assunte in materia di educazione e insegnamento, come definite dal protocollo.
La Corte afferma che il crocifisso è “prima di tutto” un simbolo religioso, ma non ritiene di disporre di «elementi attestanti l’eventuale influenza che l’esposizione sui muri delle aule di un simbolo religioso potrebbe avere sugli allievi», e anche se la ricorrente considera l’esposizione del crocifisso come una violazione dei suoi diritti, la sua «percezione soggettiva» non è sufficiente, in sé, a considerare violato l’articolo 2 del protocollo n° 1.
Il governo italiano afferma che la presenza del crocifisso è il frutto di un’evoluzione storica, e sottolinea il valore non solo religioso, ma anche culturale e identitario; quindi si tratta di perpetuare una tradizione, in nome di valori e principi che sarebbero a fondamento della democrazia e della civiltà occidentale. La Corte, anche se in linea di principio non ammette che una tradizione possa giustificare una violazione della CEDU, è d’accordo con la posizione secondo la quale «la decisione di perpetuare una tradizione rientra in principio nel margine di apprezzamento dello stato» (paragrafo 68).
Sul significato del crocifisso, poi, la Corte nota le divergenze notevoli esistenti nella giurisdizioni italiane (corte di cassazione e consiglio di stato), fa osservare che la corte costituzionale non si è espressa in merito al caso di specie e conclude che in ogni caso non è suo compito prendere posizione su tali divergenze tra giudizi nazionali.
Il margine di apprezzamento dello stato è comunque ribadito nel caso di specie, con i limiti sopra esposti, e include il diritto di esporre il crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche, anche alla luce della mancanza di un consensus europeo in materia (paragrafo 70). Anche se tale potere discrezionale è sottoposto al vaglio della Corte (perché non è illimitato), e anche se la Corte riconosce che con l’esposizione del crocifisso lo stato italiano conferisce alla religione maggioritaria una «visibilità preponderante», ciò non configura una forma di indottrinamento, quindi non viola l’articolo 2 del protocollo n° 1.
La Corte si associa poi all’idea (sostenuta dal governo italiano) che il crocifisso sia un simbolo essenzialmente «passivo», e ritiene così che il principio di neutralità sia stato rispettato, dato che non vi è stata un’imposizione «positiva» (ad esempio in un’influenza sugli allievi esercitata tramite l’insegnamento o la partecipazione ad attività religiose).
La grande camera della Corte, contrariamente a quanto deciso nel 2009 dalla camera, ritiene poi che non sia possibile affermare che i due figli della signora Lautsi siano stati vittima di un notevole impatto del crocifisso, simbolo religioso forte paragonabile al velo islamico nel caso Dahlab. La grande camera ricorda che le circostanze dei due casi (Lautsi e Dahlab) sono diverse, quindi decide di non assimilarli.
La grande camera relativizza poi la maggiore visibilità data alla religione cristiana con l’esposizione del crocifisso nelle aule, dato che a tale esposizione non è abbinata l’obbligatorietà dell’insegnamento religioso (cattolico) e la scuola italiana è aperta alle altre religioni e convinzioni, e cita a sostegno le stesse considerazioni esposte dal governo italiano a proposito di velo islamico, ramadan, etc. (v. sopra).
La sentenza continua quindi a confutare le tesi della violazione, affermando che gli stessi ricorrenti non si sono mai lamentati di essere vittime di proselitismo, e sottolinea (come il governo italiano) che la ricorrente potrà sempre, come genitore, nell’esercizio della sua «funzione naturale» di educatore, far valere le sue «convinzioni filosofiche» nei confronti dei figli.
Da tutto ciò risulta, in conclusione, che esponendo il crocifisso le autorità italiane «hanno agito nei limiti del margine di apprezzamento» di cui dispone lo stato nel quadro del suo obbligo di rispettare, nel quadro delle funzioni che assume nel settore dell’educazione e dell’insegnamento, il diritto dei genitori di veder garantiti tale educazione e tale insegnamento conformemente alle loro convinzioni religiose e filosofiche. Per cui, non c’è stata violazione dell’articolo 2 del protocollo n° 1, e «nessuna questione distinta» si pone, nel caso di specie, riguardo all’articolo 9 della CEDU. Per le stesse ragioni, inoltre, la stessa conclusione vale anche per il secondo e il terzo ricorrente, ossia per i due figli della prima ricorrente. Tale decisione di non violazione è stata adottata dalla grande camera a maggioranza, con quindici voti a favore e due contro.
I ricorrenti hanno anche lamentato di essere vittime di una differenza di trattamento, quindi di una discriminazione, non essendo cattolici, a causa dell’esposizione del crocifisso, rispetto ai genitori e agli altri allievi di religione cattolica (violazione dell’articolo 14 della CEDU). In effetti, i ricorrenti ritengono che tale discriminazione rafforza la violazione del protocollo e dell’articolo 9. All’unanimità la grande camera non ritiene tuttavia che tale discriminazione esista. Del resto, dato che la violazione dell’articolo 14 non è autonoma («non ha esistenza indipendente»), avrebbe dovuto essere collegata alla violazione del protocollo o dell’articolo 9, ma la grande camera ha escluso tali violazioni «principali», quindi la violazione «combinata» dell’articolo 14 non è in nessun caso ipotizzabile.
Oltre al parere dissenziente di due giudici (v. oltre), vi sono stati tre pareri concordanti: del giudice Rozakis (Grecia), al quale si è associato il giudice Vajić (Croazia), del giudice Bonello (Malta) e del giudice Power (Irlanda). Non starò a soffermarmi a lungo sui pareri concordanti, benché presentino alcune valutazioni di grande interesse, dato che riprendono in sostanza le motivazioni della sentenza, accentuandone alcuni aspetti, a seconda dei casi.
Vorrei solo fare alcuni brevi commenti in proposito. Nel parere Rozakis-Vajić mi sembra interessante il riferimento al concetto di proporzionalità che deve esistere, nel caso di specie, tra due esigenze fondamentali e concorrenti protette dalla CEDU e dal suo primo protocollo: quella della ricorrente riguardo al rispetto delle sue convinzioni filosofiche, da un lato, e quella – prevalente – di gran parte della società a esporre i simboli religiosi, dall’altra.
Nello stesso parere si fa poi riferimento, inter alia, alla mancanza di un consensus europeo sul’esposizione dei simboli religiosi, concludendo che la Corte deve tener conto delle legislazioni dei paesi europei in vigore, che solo in alcuni casi vietano l’esposizione di tali simboli. Quindi, se la Corte vuole riconoscere al cittadino (ad esempio nel settore della libertà religiosa) una protezione più elevata di quella garantita in uno stato determinato, può farlo solo quando ci sia almeno una forte tendenza a accordare tale maggiore protezione in un gran numero di stati europei.
Il parere del giudice Bonello riprende l’idea del crocifisso come simbolo dell’identità nazionale radicato nella tradizione, quindi abbonda nel senso della non violazione e diffida dal lanciare una «crociata per la demonizzazione del crocifisso». Altrimenti la Corte soffrirebbe di un «Alzheimer storico», con la conseguenza di «rubare agli italiani una parte della loro personalità culturale», e si renderebbe «complice di un atto maggiore di vandalismo culturale».
Il giudice Power cita nel suo parere la sentenza Buscarini contro San Marino (v. sopra), per affermare che la violazione dell’articolo 9 della CEDU si può ravvisare solo quando vi sia una «coercizione» e non una semplice «offesa», come nel caso di specie. E il crocifisso esposto nelle aule, essendo un simbolo «passivo», non ha nulla di coercitivo e non si può parlare in tal caso di violazione della neutralità dello stato.
Il parere dissenziente del giudice Malinverni (Svizzera), al quale si è associato il giudice Kalaydjeva (Bulgaria), invece, sostiene la tesi della violazione, riprendendo in gran parte le motivazioni della camera della Corte (della quale non facevano parte né il giudice Malinverni né il giudice Kalaydjeva), che aveva deciso in tal senso, all’unanimità, il 3 novembre 2009. Malinverni contesta la sentenza di grande camera innanzitutto sul terreno fondamentale del margine di apprezzamento dello stato. Secondo tale sentenza l’esposizione del crocifisso nelle aule, come abbiamo visto, rientrerebbe in tale margine, quindi lo stato italiano non avrebbe commesso la violazione del primo protocollo e dell’articolo 9. Questo assunto non convince affatto il giudice svizzero. Tale margine – spiega – è variabile in funzione di un gran numero di parametri (diritto applicabile, gravità della lesione, esistenza di un consensus europeo, etc.) e in funzione del contesto, ed è primordiale l’importanza che viene attribuita, caso per caso, a tali variabili. Il consensus europeo, di importanza essenziale, non esiste a favore dell’esposizione del crocifisso, e pochissimi stati prevedono tale esposizione come obbligatoria. Dato che il settore educativo è particolarmente delicato, l’inesistenza di un tale consensus europeo dovrebbe portare a un’interpretazione restrittiva, ossia a una limitazione del margine di apprezzamento dello stato, e non ad una sua interpretazione estensiva. In altri termini, tale inesistenza non è a favore del diritto dello stato a esporre il crocifisso nelle aule, ma al contrario è una ragione per negare tale diritto, dato che il principio del margine di apprezzamento va interpretato a tutela dei diritti dell’individuo (titolare dei diritti sanciti dalla CEDU) nei confronti dello stato, e non a vantaggio dello stato.
Inoltre, la base legale dell’esposizione del crocifisso è, in Italia, estremamente debole, trattandosi di norme vetuste (in particolare del periodo fascista), non aventi valore legislativo. Norme che non emanano dal parlamento, quindi sprovviste di una qualsivoglia legittimazione democratica. Le corti supreme e costituzionali nazionali di diversi stati europei (v. sopra) chiamate a pronunciarsi sulla questione, inoltre, hanno sempre e senza eccezione sottolineato la preminenza del principio di neutralità confessionale dello stato.
La CEDU (articolo 9) e il suo primo protocollo impongono allo stato un obbligo positivo, quello di creare «un clima di tolleranza e di mutuo rispetto» nella popolazione. E il margine di apprezzamento dello stato, che deve essere sempre sottoposto al controllo della Corte, si riduce quando esiste un obbligo positivo dello stato. Ora, quando uno stato riconosce – con l’esposizione del crocifisso nelle aule – una «visibilità preponderante» alla religione maggioritaria della popolazione, si ha una violazione dell’articolo 2 del protocollo, contrariamente a quanto ha deciso la grande camera. Viviamo oramai, continua il giudice Malinverni, in una società multiculturale nella quale la libertà religiosa e il diritto all’educazione richiedono una stricte neutralité dello stato nel settore dell’insegnamento pubblico, dove il pluralismo educativo è un elemento fondamentale del concetto di società democratica difesa dalla CEDU. Tale principio di neutralità (e di imparzialità), inoltre, è stato riconosciuto espressamente dalla giurisprudenza nazionale, ai massimi livelli. E in applicazione dell’articolo 2 del primo protocollo lo stato è obbligato a dispensare un insegnamento obiettivo, critico e pluralista, in una scuola che sia luogo di incontro di diverse religioni e convinzioni filosofiche.
Il crocifisso è senza dubbio un simbolo religioso, e la sua esposizione va aldilà dell’uso di simboli in un contesto storico specifico. Del resto, il rispetto delle tradizioni di un paese non è stato ammesso dalla Corte come «legittimo» a proposito del giuramento sui vangeli, considerato contrario all’articolo 9, dato appunto il suo carattere religioso, nella sentenza Buscarini (v. sopra). Il crocifisso, in effetti, ha un significato soprattutto religioso, anche se gli si possono attribuire significati diversi.
Rispetto alla libertà religiosa e al diritto all’educazione degli allievi, l’esposizione del crocifisso è ancora più lesiva di certi «segni religiosi» nell’abbigliamento, come ad esempio il velo islamico, dato che l’insegnante che porta il velo può farlo in nome della sua libertà religiosa (che lo stato deve, a certe condizioni, rispettare), mentre lo stato non ha nessun diritto del genere, dovendo restare neutrale. In altre parole, per la neutralità dello stato tollerare il velo islamico di un insegnante è meno grave che imporre la presenza del crocifisso. Esporlo a scuola, poi, è ancora più grave che esporlo in altri pubblici locali, perché tale imposizione è fatta su alcuni allievi, ai quali manca ancora la capacità critica di assumere il dovuto distacco rispetto a una scelta preferenziale dello stato. Occorre quindi, conclude il giudice, una neutralità confessionale particolarmente forte, e lo stato non dovrebbe imporre agli allievi della scuola dell’obbligo (contro la loro volontà e senza che possano evitarlo) il simbolo di una religione nella quale non si riconoscono. Avendo fatto tale scelta, lo stato italiano ha violato l’articolo 2 del protocollo e l’articolo 9 della CEDU.
Sono infine da segnalare altre sentenze della Corte, relative al velo islamico. Anche se riguardano anch’esse l’esercizio della libertà religiosa nel settore dell’istruzione, esiste tuttavia una differenza fondamentale rispetto al caso Lautsi, dato che in quei casi è stato invocato dalle ricorrenti, nei confronti dello stato, il diritto a portare il velo come espressione della loro libertà di religione, mentre nel «caso del crocifisso» si è trattato del diritto dello stato a imporne la presenza.
Nel caso Leyla Şahin contro Turchia (sentenza di grande camera del 10 novembre 2005), alla ricorrente, studente in medicina all’università di Istanbul, è stato vietato di indossare il velo islamico durante i corsi e gli esami, in base a una circolare del 1998. La Corte ha considerato che la Turchia non ha violato, in questo caso, l’articolo 9, dato che il velo era già stato considerato contrario alla costituzione dalla corte costituzionale. Determinante, anche in questo caso, il margine d’apprezzamento dello stato: vietare il velo è stata considerata un’ingerenza nella libertà religiosa della ricorrente, certo, ma giustificata perché «necessaria in una società democratica» (articolo 9, secondo comma). In particolare, sempre secondo la Corte, va considerato che indossare il velo potrebbe avere un impatto negativo sulle studentesse che non lo portano, potendo far pensare loro che si tratta di un vero obbligo religioso, in una società nella quale le questioni legate alla religione sono particolarmente sensibili.
Un altro caso in materia, al quale ho già fatto riferimento, è quello di una maestra convertita all’islam alla quale è stato vietato di indossare il velo islamico durante l’insegnamento (decisione della direzione della scuola, confermata dal tribunale federale svizzero nel 1997). La Corte ha concluso per la non ricevibilità del ricorso, dato che il divieto delle autorità svizzere non è stato «irragionevole», tenendo conto del fatto che i bambini affidati alla ricorrente erano particolarmente influenzabili data la loro età, compresa tra i quattro e gli otto anni (sentenza Dahlab contro Svizzera del 15 febbraio 2001)21.
Altre decisioni della Corte di particolare interesse su segni o simboli religiosi, che mi limito a citare in questa sede e alle quali rinvio, sono: El Morsli contro la Francia (4 marzo 2008), Dogru contro la Francia (4 dicembre 2008), la decisione del 30 giugno 2009 di non ricevibilità di sei ricorsi contro la Francia (Aktas, Bayrak, Gamaleddin, Gazal, J. Singh e R. Singh), tutte riguardanti dei musulmani, e la sentenza Ahmet Arslan e altri del 23 febbraio 2010.
Conclusione
La Corte ha prodotto negli ultimi anni una giurisprudenza sulla libertà religiosa, anche rispetto al settore dell’educazione e dell’istruzione, che tiene conto delle differenze di ogni fattispecie considerata, senza poter determinare sempre e a priori, e in ogni caso, quale sia la soluzione più conforme alla CEDU. Da un lato, questa diversità è giustificata dalla necessità di adattare le decisioni di Strasburgo a tutta una serie di elementi che variano a seconda dei casi e delle persone coinvolte. Dall’altro lato, la differenza tra le sentenze emesse su casi simili, o addirittura sullo stesso caso (e mi riferisco al caso Lautsi, nel quale la grande camera ha deciso in maniera diametralmente opposta a sedici mesi di distanza), sottolineano la difficoltà di prevedere in anticipo quale siano le regole «esatte» da applicare, anche a livello nazionale, in casi simili. La questione principale resta l’estensione effettiva del margine d’apprezzamento, ossia la portata del potere discrezionale dello stato nel regolare, a livello interno, certe questioni senza incorrere in una sentenza di violazione a Strasburgo. In ogni caso, la «sentenza sul crocifisso» del 18 marzo 2011 sembra aver aperto una nuova fase nella quale il principio di neutralità confessionale viene delineato riconoscendo allo stato il diritto a far valere le sue tradizioni, con le sue specificità storiche e culturali, quindi religiose.
Note
1 Presidente dell’associazione Orient-Occident (Strasburgo). L’autore si esprime a titolo personale.
2 In materia mi permetto di rinviare a due miei lavori: Médias et religions dans la troisième Rencontre du Conseil de l’Europe sur la dimension religieuse du dialogue interculturel, atti del Forum di Lisbona (2010) e La contribution aux droits de l’homme des Rencontres du Conseil de l’Europe sur la dimension religieuse du dialogue interculturel, atti del Forum di Lisbona (2009). www.coe.int/t/dg4/nscentre.
3 Per un approfondimento della materia rinvio al mio articolo La Liberté de Religion et la Convention européenne des Droits de l’Homme, in «Bulletin des Droits de l’Homme », 9 (2000), pp. 89-98, riprodotto anche in un mio volume di recente pubblicazione, Droit, Histoire et Religion, Strasbourg, 2010, pp. 93-110.
4 Convenzione del Consiglio d’Europa di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, aperta alla firma il 4 novembre 1950 ed entrata in vigore il 3 settembre 1953.
5 Primo protocollo alla convenzione del Consiglio d’Europa di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, aperto alla firma il 20 marzo 1952.
6 I tre ricorrenti sono stati rappresentati nelle varie fasi della procedura dall’avvocato Niccolò Paoletti, del foro di Roma.
7 Oltre al giudice italiano, Vladimiro Zagrebelsky, la camera comprendeva i giudici dei seguenti paesi: Belgio, San Marino, Lituania, Serbia, Ungheria e Turchia.
8 Dei seguenti stati: Belgio (presidente), Portogallo, Italia, Lituania, Serbia, Ungheria e Turchia.
9 Dei seguenti stati: Francia (presidente), Grecia, Regno Unito, Danimarca, Andorra, Malta, Croazia, Estonia, Russia, Norvegia, Finlandia, Svizzera, Cipro, Irlanda, Bulgaria, Moldova, Italia (dal 5 maggio 2010 è in carica il giudice Guido Raimondi).
10 In ordine alfabetico per stato: Stepan Kartashyan (Armenia), Andrey Tehov (Bulgaria), Yannis Michilides (Cipro), Vasileia Pelekou (Grecia), Darius Simaitis (Lituania), Joseph Licari (Malta), Georgy Matiyushkin (Russia), Guido Bellatti Ceccoli (San Marino).
11 Il testo della costituzione italiana repubblicana (entrata in vigore nel 1948) si trova su internet: www.governo.it/Governo/Costituzione/CostituzioneRepubblicaItaliana.pdf
12 Va precisato in effetti che la corte costituzionale può dichiarare la contrarietà alla costituzione di leggi ordinarie dello stato, mentre le norme amministrative (di rango inferiore) non rientrano nel suo ambito di competenza.
13 Vedasi, contra, G. Badini Confalonieri, Il principio di laicità dello stato e le immagini sacre nei locali pubblici. Commento alla sentenza della corte di cassazione penale n° 4273 del 1° marzo 2000, in «I Tre Anelli – Les Trois Anneaux», 5 (2002), pp. 87-97.
14 In tali territori vige il concordato del 1801 tra Francia e chiesa cattolica, esteso successivamente ai protestanti e agli ebrei (ma non ai musulmani). Tale concordato riconosce ai gruppi religiosi citati uno statuto particolare rispetto a quanto avviene nel resto della Francia, dove vige la legge del 1905 sulla laicità dello stato.
15 La corte costituzionale polacca è stata investita della questione dall’ombudsman (mediatore), relativamente all’ordinanza del ministro dell’educazione del 14 aprile 1992 che prevede l’esposizione del crocifisso nella aule delle scuole pubbliche.
16 Si tratta di una decisione presa a seguito di una richiesta, formulata da un’associazione di difesa della laicità della scuola, tesa a far togliere i simboli religiosi nelle scuole. Dato che tale richiesta non ha avuto successo, la questione è stata sottoposta al tribunale citato.
17 Ai sensi dell’articolo 5, quinto comma, del protocollo n° 11, entrato in vigore il 1° novembre 1998, che ha riformato il sistema di controllo sopprimendo la commissione dei diritti dell’uomo e facendo della Corte un organismo che siede in maniera permanente.
18 Paragrafo 5 del parere dissenziente. Mia traduzione dal francese.
19 La ricorrente, secondo il governo italiano, sarebbe una militante della Unione degli atei e degli agnostici razionalisti (sentenza di grande camera, paragrafo 35, in fine).
20 Sentenza Otto-Preminger-Institut contro l’Austria del 20 settembre 1994.
21 In materia di velo islamico consiglio la lettura di W. e K. Sahlfeld, Le foulard à l’école. “Symbole religieux fort” ou simple différence culturelle?, in «I Tre Anelli – Les Trois Anneaux», 3 (2002), pp. 87-93.
Share this content: