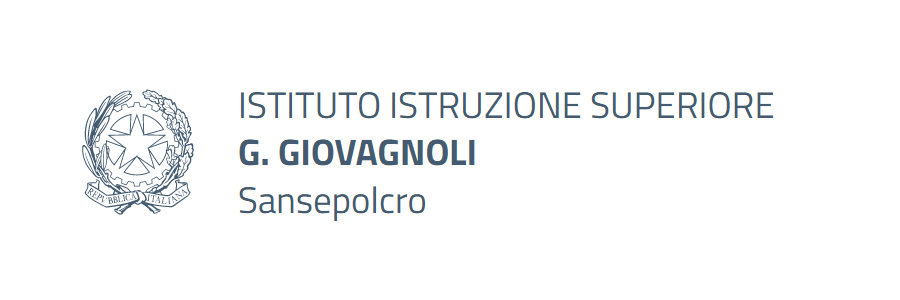Famiglia Cristiana n.52 del 28 Dicembre 2008
I Territori palestinesi e la Giordania non hanno una chirurgia pediatrica. Ora si vuole costruirla a Betlemme.
Le ragioni per credere non mancano. Mancano a volte quelle per restare. Così il destino dei cristiani di Terra Santa si complica, spesso si perde lungo le vie della diaspora e dell’esilio. E il compito dei loro pastori diventa immane, si scontra con una realtà di violenza e rancori che, da un secolo, sembra lavorare contro di loro, al solo scopo di smantellare le residue ragioni di speranza.
D’altra parte, chi ha provato a sentire i circa 50 mila cristiani che vivono in Cisgiordania (su circa 2 milioni di abitanti) ha capito quanto possa pesare ogni singolo gesto, ogni esigenza grande o piccola della vita quotidiana. Nel 2006, il Sabeel Center di Gerusalemme chiese ai palestinesi cristiani, con un sondaggio del sociologo Bernard Sabella, per quali ragioni volessero emigrare: la mancanza di lavoro e la gravità della situazione politica davano il 90% delle risposte.
Piccoli pazienti ai piedi del Muro
È da seguire con trepidazione ed entusiasmo, dunque, lo sviluppo di un progetto che parte dall’Italia, proprio per costruire, insieme con il Patriarcato latino di Gerusalemme, un’ulteriore, concreta ragione di speranza nel futuro: una clinica di chirurgia pediatrica a Beit Jala, il villaggio che, con Beit Saour (il villaggio dei pastori) e Betlemme, raccoglie il nucleo più compatto e numeroso dei cristiani che vivono nei cosiddetti Territori palestinesi. Per capire fino in fondo l’importanza dell’iniziativa, occorre riassumere in breve le condizioni sanitarie in cui si trovano i bambini palestinesi. Le esigenze della medicina pediatrica sono coperte dal Baby Hospital di Betlemme e da altre strutture minori. Manca, invece, sia nei Territori, sia in Giordania, una qualunque struttura, pubblica o privata, per la chirurgia, l’anestesia e la rianimazione pediatrica.
Oggi, quando un bambino ha un problema così serio da imporre l’intervento chirurgico, deve per forza chiedere un ricovero in Israele. Questo significa dover passare il Muro (o Barriera di separazione, come lo chiamano gli israeliani), cioè ottenere un permesso d’ingresso da parte delle forze di sicurezza d’Israele per il bambino e per un accompagnatore, di solito un parente. I militari israeliani sono spesso comprensivi, ma non possono infrangere certe regole: se la famiglia del bambino è schedata per qualche ragione (ed è facile che succeda, visto che un terzo dei palestinesi è stato arrestato almeno una volta), il permesso non arriva. O arriva troppo tardi: non sono pochi i casi di bambini morti mentre aspettavano. Se poi il permesso arriva, bisogna garantire alle strutture sanitarie di Israele che il costo delle cure sarà coperto: non sono pochi i casi di famiglie palestinesi che hanno dovuto vendere la casa per salvare la salute o la vita dei figli.
Per intervenire su tutto questo, cioè su un processo che provoca sofferenze fisiche e una spirale ininterrotta di rancori, si è mossa la Conferenza episcopale italiana (in particolare l’Ufficio per gli interventi caritativi per i Paesi del Terzo Mondo), che garantisce un primo, fondamentale nocciolo dell’imponente cifra necessaria per il reparto di chirurgia: 4 milioni di euro. Il resto tocca al braccio operativo del progetto, la Fondazione Giovanni Paolo II, nata nell’ambito delle diocesi di Fiesole e di Montepulciano-Chiusi-Pienza, che da più di un decennio collabora, appunto, con la Conferenza episcopale.
«Il nostro compito», spiega Angiolo Rossi, direttore della Fondazione, «è di aggregare e coordinare i più diversi soggetti, siano essi espressione del mondo laico o ecclesiale, intorno a determinati progetti, per garantire non solo un adeguato finanziamento, ma anche una realizzazione pari alle esigenze e alle attese della popolazione. Troppi interventi sono ancor oggi calati dall’alto, senza un’approfondita conoscenza delle realtà locali. E troppi, quindi, sono ancora gli sprechi o i risultati inferiori alle reali possibilità».
La collaborazione con l’Italia
La Fondazione ha operato e opera tuttora in Israele (un centro per la gioventù a Gerusalemme), Libano (un ospedale nella diocesi cattolico-maronita di Tiro), Siria e Territori Palestinesi. Per l’intervento a Bei Jala ha mobilitato il proprio ufficio di Gerusalemme, diretto dal padre francescano Ibrahim Faltas. Proprio in base alle ricerche sul campo, si è deciso di non procedere alla costruzione di un nuovo ospedale (cosa che avrebbe anche fatto lievitare i costi), ma piuttosto di preparare una nuova struttura (quella, appunto, chirurgica) da allegare al plesso ospedaliero già esistente. Si tratta della Arab Society for Rehabilitation, azienda ospedaliera presieduta dallo stesso patriarca Twal, che si prenderà in carico la futura chirurgia. «In ogni caso», specifica Rossi, «il rapporto sarà regolato da un protocollo d’intesa con effettiva valenza contrattuale, che è ormai quasi pronto».
Intanto, la Fondazione lavora: la progettazione del nuovo presidio medicochirurgico avanza con la collaborazione degli specialisti dell’Ospedale pediatrico Meyer di Firenze, cioè ai massimi livelli. I lavori dovrebbero partire nel 2009. Molte cose sono ormai pronte. Siamo pronti, noi, a dare una mano?
Fulvio Scaglione
Share this content: